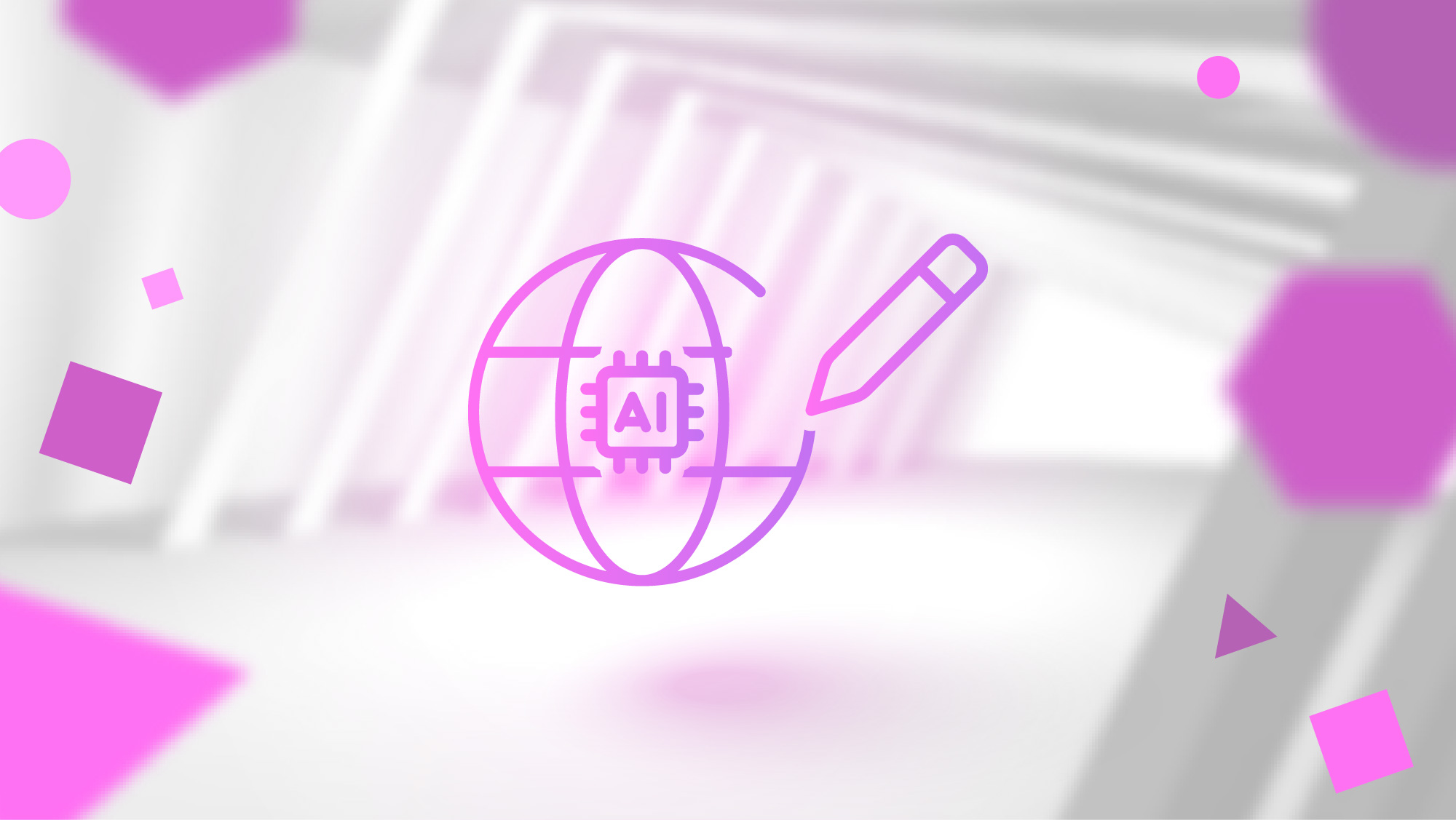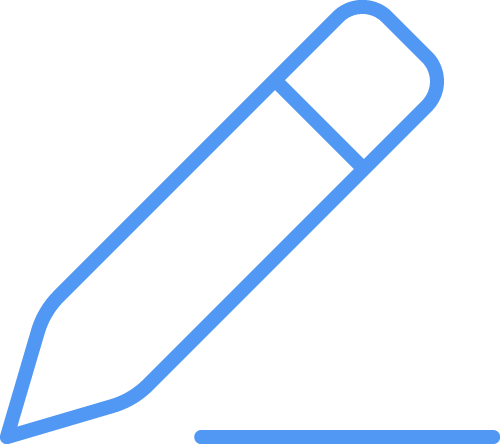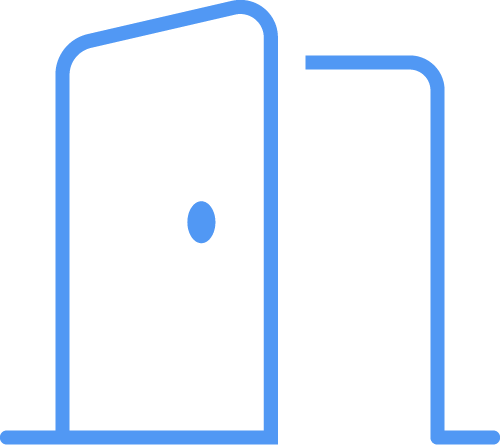Il Consiglio d’Europa (da non confondere con il Consiglio europeo) lo scorso 17 maggio ha approvato il primo trattato sull’intelligenza artificiale, diventato giuridicamente vincolante nel settembre 2024. Il trattato è volto a garantire il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.
Il documento è il frutto del lavoro dell’organismo intergovernativo del Comitato sull’intelligenza artificiale (CAI) di cui fanno parte i 46 Stati membri dell’Unione europea e Stati Uniti, Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, Giappone, Israele, Messico, Perù, Vaticano e Uruguay, insieme a rappresentanti del settore privato e accademici.
La Convenzione quadro firmata da questi paesi stabilisce un quadro giuridico relativo all’intero ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale, tenendo conto dei rischi che possono presentarsi. L’approccio, come l’
I principi cardine da tutelare sono il divieto di discriminazione e la privacy in ogni circostanza. La Convenzione mira alla massima trasparenza dei processi che si nascondono dietro i sistemi di intelligenza artificiale e cerca di limitare il più possibile i pericoli per tutelare i cittadini. Inoltre, gli Stati devono assicurare che i sistemi non vengano utilizzati per compromettere le istituzioni e l’accesso alla giustizia.
I principi cardine da tutelare sono il divieto di discriminazione e la
Vi è una chiara volontà di procedere verso il progresso, non trascurando i diritti fondamentali e i trattati internazionali sanciti e garantiti fin qui. Il trattato è stato redatto con uno spirito collaborativo di cooperazione internazionale, essendo stato aperto anche ad altri paesi al di fuori del continente europeo. Gli obiettivi delineati sono chiari e i paesi hanno facoltà di agire in modo autonomo, fermo restando sulle finalità da raggiungere. La dignità umana deve essere al centro di ogni sviluppo e vanno definite le rispettive responsabilità.
La Convenzione quadro ha una portata storica e insieme all’
Anche qui, la visione antropocentrica è il focus principale. Procedere all’innovazione e al progresso, sempre però in funzione della persona, salvaguardando i suoi diritti e le sue libertà. L’Unione europea, ancora una volta con quest’ulteriore partecipazione, ha dimostrato un atteggiamento pionieristico e si pone come precursore nella regolamentazione delle nuove tecnologie, così come hanno fatto la Corea del Sud e, su tutti, il Regno Unito. Il grande potenziale di questi nuovi sviluppi tecnologici necessita di confini per limitare gli impatti negativi. I paesi più sviluppati hanno compreso che è preferibile un approccio collaborativo a livello globale piuttosto che viaggiare ognuno per conto suo, cosa che potrebbe creare più danni che benefici. Solo attraverso standard condivisi non si avranno sorprese e il progresso tecnologico sarà vantaggioso per tutti.
A distanza di ormai un anno da questi vertici, l’intelligenza artificiale ha continuato ad evolversi, così come i rischi ad essa associati. Per questo è opportuno continuare su questa strada di collaborazione internazionale per regolamentare al meglio tutti gli aspetti di questa nuova tecnologia.