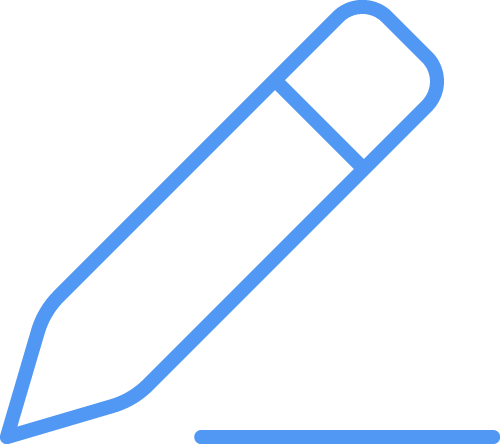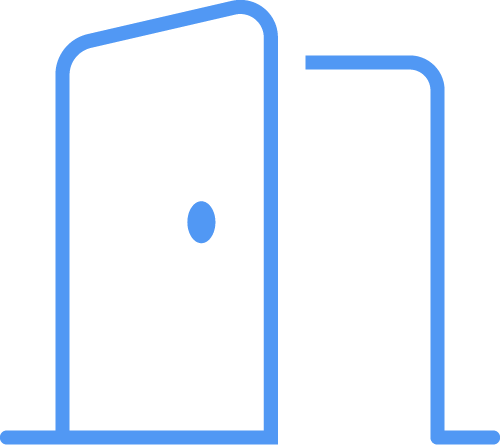Negli ultimi tempi si sono molto diffusi i termini
Dalla telemedicina ai robot chirurgici, le tecnologie informatiche applicate al campo medico stanno assumendo un’importanza crescente a livello internazionale. Il settore della sanità digitale comprende un ampio ventaglio di applicazioni, come i servizi sanitari a distanza, cartelle cliniche digitali, applicazioni per la salute in condivisione con il medico, prescrizioni elettroniche e molte altre ancora.
I dati sanitari sono considerati dati sensibili, ovvero rientrano in quella categoria di dati personali che richiedono una protezione maggiore. Questi, infatti, custodiscono informazioni estremamente private e delicate sulla nostra vita personale, che possono essere utilizzate in modo improprio contro di noi. I dati sensibili sono quelli che rivelano la nostra origine etnica, l’orientamento religioso, sessuale e politico, e lo stato di salute. Una violazione potrebbe portare a discriminazioni e altre conseguenze negative. Per questo motivo, il diritto alla privacy in ambito sanitario è fondamentale.
I dati sanitari sono considerati dati sensibili, ovvero rientrano in quella categoria di dati personali che richiedono una protezione maggiore. Questi, infatti, custodiscono informazioni estremamente private e delicate sulla nostra vita personale, che possono essere utilizzate in modo improprio contro di noi. I dati sensibili sono quelli che rivelano la nostra origine etnica, l’orientamento religioso, sessuale e politico, e lo stato di salute. Una violazione potrebbe portare a discriminazioni e altre conseguenze negative. Per questo motivo, il diritto alla privacy in ambito sanitario è fondamentale.
Regolamentazione dei dati sanitari
La gestione dei dati è sempre stato un tema di preminente rilevanza in ambito medico – sono oggetto del segreto professionale, infatti – ma la crescente digitalizzazione, anche di questo settore, ha posto sfide maggiori e una necessità di rafforzare la regolamentazione con leggi più stringenti al fine di tutelare la privacy dei pazienti.
A dare le risposte più esaustive è stato il
Oltre al
Altri passi avanti si stanno compiendo per regolamentare la sanità digitale. Di recente, infatti, il Parlamento e Consiglio Ue hanno approvato la proposta della Commissione di creare uno Spazio europeo dei dati sanitari (EHDS), volto a migliorare la gestione dei dati sanitari nello spazio europeo e permettere ai cittadini maggiore accessibilità e controllo sui loro dati in tutto il territorio europeo.
I dati sanitari, come è noto, sono particolarmente utili per la ricerca. Il crescente scambio di dati sensibili online aumenta il rischio di violazioni e furti. Per proteggerli, vi sono varie precauzioni che i ricercatori devono prendere. Ad esempio, lo scambio deve avvenire in modo criptato, ovvero per visualizzarli si deve inserire una password, o crittografato con algoritmi. La crittografia è fondamentale, come si evince dall’art. 32 del GDPR, anche nella telemedicina, dove si necessita di una protezione elevata. Questo sistema rende illeggibili i dati, che sono svelabili solo con una chiave di decriptazione, e ciò ne favorisce la segretezza e l’integrità.
I dati sanitari, come è noto, sono particolarmente utili per la ricerca. Il crescente scambio di dati sensibili online aumenta il rischio di violazioni e furti. Per proteggerli, vi sono varie precauzioni che i ricercatori devono prendere. Ad esempio, lo scambio deve avvenire in modo criptato, ovvero per visualizzarli si deve inserire una password, o crittografato con algoritmi. La crittografia è fondamentale, come si evince dall’
L’accesso ai dati sensibili è limitato solo al personale autorizzato, che può accedervi dai dispositivi del laboratorio o dell’ente di ricerca, entrambi collegati ad un indirizzo
Per evitare la re-identificazione del paziente in caso di violazione, esistono varie tecniche di anonimizzazione dei pazienti, come la generalizzazione e il raggruppamento dei dati solo per aree geografiche o fasce d’età o l’eliminazione di attributi specifici utili all’identificazione. Un altro elemento di protezione è la pseudonimizzazione, che consiste nel sostituire gli elementi identificativi del paziente con altri non direttamente collegabili alla sua identità; in alternativa, è possibile identificarli con numeri o codici.
Anche con le tecniche più sofisticate, però, esiste sempre il rischio che i dati possano essere ricondotti a un individuo specifico, soprattutto se combinati con altre fonti di informazioni. Una controindicazione di queste metodologie è la limitazione dell’utilizzo, che rischia di far perdere informazioni utili alla ricerca e allo sviluppo tecnologico stesso. Le barriere legali che esistono per la limitazione dei dati in ambito sanitario servono per tutelare la privacy dei pazienti, ma spesso le aziende produttrici di sistemi sanitari digitali richiedono l’accesso ai dati per ricercare e creare soluzioni innovative e personalizzate senza ostacoli. È fondamentale bilanciare la privacy con l’utilità del dato per la ricerca, valutando gli impatti di ogni tecnica di anonimizzazione e gli eventuali rischi di re-identificazione.
Inoltre, un altro aspetto da sottolineare è che se da una parte i dati sanitari necessitano di una particolare riservatezza, dall’altra vige il diritto di condivisione per forza maggiore: la sanità pubblica. Come ha dimostrato la pandemia, i cittadini hanno il diritto di conoscenza riguardo ad una malattia trasmissibile per poter prendere misure precauzionali. La diffusione di tali informazioni deve essere ovviamente limitata alla prevenzione.
L’Intelligenza artificiale per migliorare la sanità
Sia nella ricerca scientifica che nel nuovo settore della telemedicina, l’intelligenza artificiale si sta impiegando per vari usi che possono migliorare l’efficienza del lavoro. Non solo, gli strumenti di
I vantaggi che un ampio impiego delle tecnologie di
Un altro utilizzo che sta proliferando in tutto il mondo è la chirurgia robotica: i robot chirurgici assistiti da IA garantiscono una precisione maggiore e interventi meno invasivi.
È da tenere sempre in conto, però, che questo avanzamento ha un prezzo e richiede misure di sicurezza sempre più robuste, per non parlare dei costi effettivi di tali strumenti e delle problematiche etiche che vengono sollevate, tra cui la questione della responsabilità. Chi è responsabile in caso di errori dell’algoritmo? Inoltre, gli algoritmi possono contenere dei
L’impatto dell’IA sulla privacy
Per quanto riguarda la gestione dei dati, invece, esistono già due strumenti digitali che hanno rivoluzionato il modo in cui vengono gestiti i dati sanitari: il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e la Cartella Clinica Elettronica (CCE). Il primo contiene tutti i dati e documenti sanitari di un paziente, comprese le terapie, mentre la cartella clinica elettronica registra tutte le visite e documenta accuratamente l’attività clinica e si va ad integrare al primo strumento. Tutta questa mole di dati ipersensibili deve essere gestita in modo appropriato, come disciplina il
Nonostante i grandi benefici che l’intelligenza artificiale può apportare alla ricerca scientifica e ai servizi sanitari, la questione relativa ai dati non è per nulla secondaria, soprattutto se pensiamo alla fase dell’addestramento. Come sappiamo, i software di intelligenza artificiale richiedono grandissime quantità di dati per apprendere ed essere altamente performanti. Nel settore sanitario, ciò diventa ancora più problematico, perché l’utilizzo di dati sensibili per addestrare gli algoritmi comporta vari rischi per la privacy. In questo caso, la protezione deve essere massima perché, anche se i dati sono anonimizzati, spesso ci sono elementi che fanno risalire all’identità del paziente.
Conclusioni
La pandemia ha costretto ad incentivare alcune pratiche di telemedicina, accresciute ulteriormente in seguito al massiccio impiego dell’intelligenza artificiale in ogni ambito. Questo connubio tra tecnologia e medicina ha però svelato le criticità legate ai dati ipersensibili. Nel nostro ambito nazionale, vi sono anche da considerare le diversità interregionali: la sanità territoriale è infatti regolamentata in modo indipendente perché di competenza regionale, e questo può contribuire alla disparità che intercorrono anche a livello di digital gap. In quest’ottica, i
La sicurezza e la continuità del lavoro sono essenziali per andare avanti senza lasciarci nulla indietro. Molte
La sanità digitale e tutte le sue applicazioni sono un potenziale unico per lo sviluppo della sanità nazionale e a livello globale: rendere le cure più efficienti e tempestive migliorerà anche la società. Minimizzare i rischi informatici, riducendo i margini di errori, favorendo la trasparenza degli algoritmi, ma soprattutto promuovendo la sicurezza dei dati sanitari dei pazienti, è una partita decisiva per lo sviluppo e il progresso di questa innovazione.