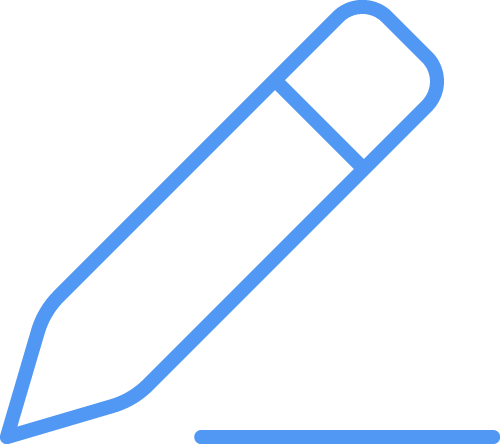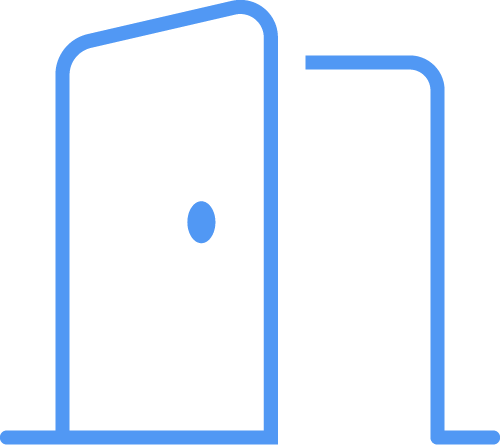Introduzione
Parlare di legal design adottando il punto di vista del
Stato dell’arte
Negli ultimi cinque anni abbiamo assistito ad un aumento nell’offerta di servizi di legal design, e certamente ad una maggiore sensibilità verso l’utente finale nel settore legale. Tuttavia, ad oggi, i professionisti del legal design non hanno ancora trovato piena condivisione su alcuni elementi fondamentali, come i) la definizione di legal design, ii) la figura del legal designer ed il suo ruolo, iii) la metodologia. Inoltre, la maggior parte dei professionisti del settore legale non ha ancora sentito parlare di legal design, e quelli che lo hanno fatto tendono talvolta a confondere concetti come
Personalmente, credo che il legal design sia una disciplina più che un
La questione linguistica riguarda anche il concetto di legal designer. È una figura specifica o qualcuno che partecipa al processo? Personalmente, credo che la definizione di legal designer per se possa essere fuorviante, perché una parte fondamentale del processo di
Detto questo, sono molto contento che sempre più professionisti con background diversi (avvocati, designer, ma anche professionisti del marketing e manager della sostenibilità) stiano scoprendo nuovi modi per sperimentare nel campo legale, tenendo conto degli utenti finali dei documenti. Uno degli aspetti positivi del legal design, infatti, è la sua potenziale gamma di applicazioni pratiche. Negli anni, ho lavorato su vari campi: dai contratti di smart working alle
Il punto di vista dei clienti. Nice to have o priorità?
Certamente, una delle questioni principali legate al successo del legal design è l’interesse dei clienti per i progetti (intendendo il cliente in senso lato, quindi anche la pubblica amministrazione e le istituzioni). Nonostante gli sforzi e l’innegabile ascesa della tematica, nonché la percezione di un bisogno reale da parte dei vari
Un altro aspetto – a volte sottovalutato – è legato al fatto che la maggior parte degli elementi positivi del legal design sono intangibili: la migliore relazione tra i dipartimenti, il diverso ruolo dei giuristi di impresa, che così assurgono a
pivot delle aziende per cui lavorano, una nuova attenzione all’utente finale, che diventa maggiormente rilevante dopo la chiusura di un progetto. Di solito, un team si rivolge ai professionisti del legal design perché ha visto un lavoro sul web, o magari ne ha sentito parlare, ma tende a non concentrarsi sul valore reale che viene offerto (il quale – sorprendentemente – potrebbe essere molto attraente per amministratori delegati e direttori finanziari, molto più interessati del team legale a concetti come l’impatto e il rafforzamento della relazione con l’utente finale di un documento).
Un altro aspetto – a volte sottovalutato – è legato al fatto che la maggior parte degli elementi positivi del legal design sono intangibili: la migliore relazione tra i dipartimenti, il diverso ruolo dei giuristi di impresa, che così assurgono a
Quale approccio per una strategia di successo?
All’interno della comunità italiana del legal design, ho potuto notare principalmente due modi di pensare. Uno è più purista: il legal design è solo quello con professionisti di diversi background, una vera metodologia di
Nonostante la preferenza per l’una o l’altra prospettiva (ad esempio, io tendo ad essere d’accordo con la prima), credo che i seguenti elementi potrebbero essere utili in ogni caso:
- Condividere un maggior numero di esempi. La progettazione di contenuti legali umanocentrici in Italia (e direi in tutto il mondo) conta ad oggi su un numero ristretto di esempi. Questo è legato anche a elementi logistici: lunghezza dei progetti, disponibilità degli uffici legali a condividere gli sforzi, accordi di riservatezza. Potremmo anche citare il nostro codice deontologico, che limita in modo significativo la comunicazione dei documenti legali.
- Rafforzare la comunità di professionisti che praticano la disciplina. In Italia possiamo fortunatamente contare su una solida base di appassionati e praticanti di legal design. Dagli incontri periodici agli articoli scritti insieme, ho fiducia nella collaborazione su progetti comuni e nella condivisione delle prospettive di lavoro sul campo.
- Coinvolgere le università. Purtroppo, la maggior parte delle università italiane è ancora poco interessata al legal design e solo un gruppo ristretto offre corsi e seminari sull’argomento: Cattolica, Trieste, Bologna, Bergamo. Siamo nella fase iniziale di un movimento che richiede impegno, investimenti e consapevolezza anche a livello istituzionale. Non è qualcosa che si può ottenere in poche settimane.
Conclusioni
Al momento ci troviamo a un bivio in termini di possibilità future per il legal design. Da un lato, vediamo tutte le ragioni per investire. Psicologiche, neurologiche, sociali, politiche, economiche. I cittadini vogliono norme migliori, gli utenti chiedono documenti legali più chiari, i professionisti del diritto sono interessati a un nuovo modo di approcciare i clienti.
Dall’altra parte, il legal design è innegabilmente difficile e costoso, soprattutto se fatto bene. E più ci spostiamo verso il legal design thinking e l’analisi d’impatto, più lo scenario diventa complesso (professionisti esperti, tempi significativi, sforzo degli attori coinvolti).
Il mercato ci dirà cosa accadrà nel prossimo futuro, ma, come italiano e ottimista per natura, il mio bicchiere è mezzo pieno. Uno dei miei istruttori di qi gong, notando la mia lotta contro la mancanza di progressi adeguati, mi disse una volta “ci vuole tempo”. Penso che in questo caso sia esattamente lo stesso. La direzione è buona, i praticanti sono appassionati, gli esempi sono sempre di più. Ci vuole solo tempo.